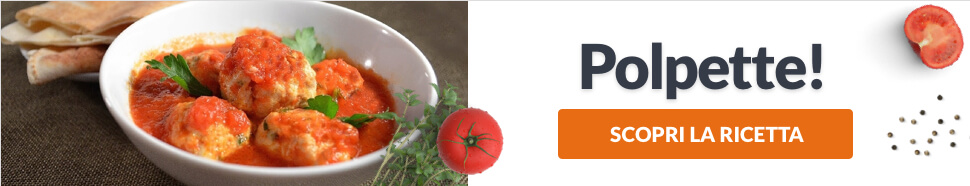Un vecchio mazzo di chiavi. Con un portachiavi da adolescente. Non l’ho mai cambiato; in fondo è come se il tempo non fosse mai passato. Andavo così orgoglioso di quel portachiavi. Una maglia dell’Athletic Bilbao con il mio cognome serigrafato, e il numero 22, la mia data di nascita. Me l’aveva portato Francesco dall’Erasmus, e da allora non l’avevo cambiato mai. Mi squilla il telefono, lo lascio suonare, sono troppo agitato, mi capita ogni volta che torno a casa, da quando mia madre soffre di una di quelle malattie che non si nominano. Cancro, dicono i medici. Tumore, i cinici. E altri nomi orrendi, che fanno cambiare espressione non appena li senti nominare. E allora li chiami “mali incurabili”, “brutte malattie”, come se cambiandone i nomi si potessero esorcizzarne gli effetti. Prendo le valige, le appoggio sull’asfalto, recupero il telefono dalla tasca del cappotto. È Sara, devo dirle che sono arrivato.
“Amore, sì tutto a posto, sono arrivato”
“Salutami tua madre”
“Certo, ti scrivo più tardi”
“Ma sei già a casa?”
“No, preferisco chiamarti adesso perché dopo vorrei parlare un po’ con lei e capire come si sente. A dopo, ti amo”.
È che in realtà non lo so cosa succederà dopo che varcherò quella porta. Quanto sarà invecchiata mia madre. Non la vedo da tre mesi, e tre mesi con quel male sono un’eternità. Provo paura, per cui prendo ancora tempo. Respiro forte, mentre la immagino intenta a prepararsi per me. Come per un primo appuntamento. Sono io il primo appuntamento di mia madre, adesso che è sola. Un rito che si ripete ogni volta che arrivo da Roma, da quando sta male ancora di più, perché lei è la mamma vuole sempre farsi trovare bella. Non in forma, non in piedi. Bella. E lei bella lo è sempre, anche adesso che non ha più capelli. Infilo le chiavi nel portone, le giro lentamente, sento lo scatto. Uno di quegli scatti che mette in allerta tutto il condomino. È tornato Erasmo, il figlio della signora Palazzo, quella che ha il tumore. Come non lo conosci? Quello che vive fuori, no non lo so che fa, forse scrive, boh per me fa il mantenuto. Casa mia a Bari è al primo piano. Sono due rampe di scale, quando ero piccolo ne salivo tre alla volta e ci mettevo 4 secondi netti. Respiro ancora più forte, salgo piano mentre sento il suono inconfondibile della porta blindata di casa mia che si apre, da dietro. È lo stesso suono dei pomeriggi d’inverno dell’epoca di Non è la Rai, quando mia madre tornava da lavoro e mio padre la aspettava sull’uscio per un bacio. Io mi giravo, perché ero un po’ geloso e poi volevo lasciargli la giusta intimità, insomma il mio ruolo non poteva essere quello del terzo incomodo. Oggi che lui non c’è più, mia madre è rimasta l’unica custode – valorosa – di quel suono. E ogni volta che salgo quei pochi gradini sento il cuore arrivare in gola, perché non so come la ritroverò. Se sarà dimagrita, se avrà le guance scavate, quanto sembrerà stanca. Ecco, quei secondi, che nel frattempo da quattro sono diventati venti, vuoi per il temporeggiare, vuoi perché pure io non scatto più come allora, sono il mio tempo sospeso di questi anni. Un rituale che si ripete ogni volta che torno. Che mi tormenta, e al tempo stesso mi rende più forte. Sono gli attimi in cui mi passano davanti i pomeriggi in cortile, il cestino di vimini con la merenda, i paradigmi sbagliati di latino e greco. Obmutesco, Obmutesces, Obmutui. Le mattine in cui lei mi accompagnava a scuola, e io avevo ancora gli occhi impiastricciati dal sonno, e facevo fatica a parlare, mentre lei premeva la frizione così forte da far sentire a tutto il quartiere che noi eravamo pronti. Penso che in fondo è tutta qui la vita: nell’intervallo tra i mesi di assenza e i secondi che ti separano dalla speranza che nulla sia cambiato. È incredibile quanto possa dilatarsi il tempo tra l’attesa e il ricordo. Tra la paura e la speranza. E come in un deja vu mi ricordo di averle fatte diecimila volte quelle scale, sempre con prospettive e aspettative diverse. Sono sempre più vicino e la porta blindata si apre piano. Ci vuole forza per tirarla e mia madre forza non ne ha più. Appare lei, invecchiata ma sempre bella, che accenna un sorriso. I miei occhi dentro i suoi sono la mia concezione di famiglia. Ed è proprio vero che quella per la salvezza del mondo è una battaglia che si combatte casa per casa. L’odore di melanzane si propaga sul pianerottolo. Le polpette di melanzane di mia madre, quelle con i capperi freschi, sono un’arma di distruzione di massa. Sarebbero capaci di fermare anche le malattie più gravi.
“Ma ti sei messa a cucinare?”
“Ehi, che io sto debole, mo’ me ne vado a terra dobbiamo mangiare”
E subito le mie paure svaniscono, o quantomeno si allontanano, davanti alla tavola bandita di caciocavallo del Gargano, pomodori freschi di Apricena, ricottine di bufala, pane di Laterza, e le sue polpette di melanzane. Ci sediamo a tavola e quel volto invecchiato mi è già più familiare. Come un destino da compiere, ma da compiere come diciamo noi.
“Come sta tua madre?” mi scrive Francesca
Le invio una foto delle polpette di melanzane.
Mi risponde con un cuore.
E io alzo lo sguardo verso di lei. Che non mi chiede più come va il lavoro, se ho il posto fisso, e quando mi sposo.
“Un po’ di sugo l’hai messo?”
“No, passamelo va’”
E già mi immagino a combattere per la salvezza del mondo tirando polpette di melanzane in faccia alle malattie più brutte. Mi godo la mia piccola famiglia e penso a come tenere con me questi ricordi per non farli andare mai via. È tutto ciò che ho. E sa di fritto, capperi e formaggio.